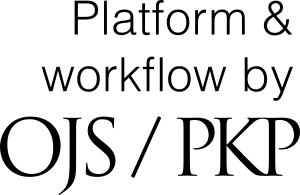La “ragione” del principe e la “dispensa morale”
Flavio Felice
“Ciò che lo Stato nazionale concede malvolentieri alle sue parti, vale a dire i diritti che spettano a ciascuno, esso si ostina invece a volere per sé”. Con queste parole, l’economista e teorico della politica Wilhelm Röpke, nell’opera “L’ordine internazionale” (1946), si interrogava sulle ragioni del disordine internazionale che, in trent’anni, aveva provocato ben due guerre mondiali. Escludendo ragioni di ordine psicologico o di sociologia delle folle, Röpke riteneva inadatto anche il riduzionismo giuridico; il “giuridicismo” appariva insoddisfacente di fronte ai ripetuti fallimenti della cosiddetta via giuridica alla pace: un equilibrio di forze nel sistema internazionale di Stati sovrani.
L’inadeguatezza della soluzione “giuridicista” impone la ricerca di risposte più complesse che vadano alla radice del problema della guerra, a prescindere se a praticare la violenza e la menzogna sia un attore personale o un ente, sollevando questioni di ordine ontologico, epistemologico e morale; dovremmo chiederci: esistono, agiscono, uccidono, soffrono, fuggono, amano gli Stati o le persone? Se adottiamo l’approccio di Röpke, di Sturzo, di Einaudi, di Hayek, di Mises e di una folta schiera di individualisti e di personalisti metodologici, la risposta è inequivocabile: esistono solo persone e la responsabilità andrebbe imputata solo in capo a loro.
È interessante osservare come Sturzo e Röpke, geograficamente distanti e rappresentanti di due differenti confessioni religiose: il cattolico Sturzo e il protestante Röpke, in due differenti momenti del Novecento, entrambi drammatici, abbiano espresso un comune sentire rispetto alla causa della guerra, individuata, primariamente, nella “dispensa morale” di cui sarebbe beneficiaria l’azione politica e, di conseguenza, il suo agente, rispetto all’ordinario agire umano. In breve, Sturzo, ne “La comunità internazionale e il diritto di guerra” (1928), e Röpke, nell’opera già citata del 1946, denunciano l’uso disinvolto della “doppia morale” per giustificare atti politici che, qualora fossero compiuti nel nome dell’interesse personale, sarebbero condannati senza alcuna riserva.
Ecco il punto centrale che trasforma una possibile composizione giuridica interstatuale, rispetto all’anarchia degli Stati, in un potenziale disordine internazionale, foriero di guerre e di devastazioni mondiali. In fondo, si chiede Röpke, a cosa servono i trattati internazionali e gli appelli agli Stati di limitare la loro sovranità, a favore di un ordine internazionale, se prevale la consapevolezza che i trattati andrebbero rispettati solo se e nella misura in cui tornino utili in questo determinato momento storico? A cosa servono i trattati internazionali se si ritiene che gli Stati vivano di vita propria, la cui logica dell’azione non risponde alle categorie morali delle persone che in essi operano? Ed ancora, a cosa servono quei trattati se “il sacro egoismo della nazione giustifica la menzogna, la non osservanza dei trattati e la violenza?”.
È questa la politica di dominio, della ragion di stato, di una certa idea di realismo, dettata dalla “doppia morale”. Un machiavellismo che, nel corso della storia, ha assunto diversi nomi e che non nasce certo con il segretario fiorentino. Sono tutte quelle situazioni in cui un comportamento, ritenuto disdicevole nel contesto della vita privata, familiare e civile, assume immediatamente un’aura di legittimità, se non di eroismo patriota, non appena venga accostato ad un soggetto collettivo, che può essere uno Stato, ma anche un’azienda, un ufficio, una qualsiasi istituzione. La realtà, denuncia Röpke, è che comunque lo si chiami, e per qualsiasi ragione sia posto in essere, rimane un atto che “emana lo stesso acuto aroma del machiavellismo, misto col profumo del positivismo scientifico”.
Invero, così come appare impossibile ogni rapporto umano, se si elevano a norma civile la menzogna, la violenza e l’inosservanza dei patti, perché ad essere calpestata è la dignità delle persone, così diventa impraticabile qualsiasi relazione politica, poiché si rompono tutti i legami di reciproca fiducia, senza i quali nessuna intesa tra Stati, in vista di un’organizzazione sovranazionale, sarebbe lontanamente immaginabile; al diritto delle genti si sostituirebbe “il diritto della giunga”.
Sintetizzando, si possono individuare tre aspetti che qualificano il rifiuto della “dispensa morale”, sulla base della quale i teorici della “doppia morale” pretendono di legittimare ogni nefandezza politica, in nome della “ragion di Stato”. In primo luogo, sebbene menzogne, violenze e tradimenti dei patti internazionali non siano certo una novità e non appartengano solo all’era statuale, ci sarebbe una sostanziale differenza tra il tradire e il vergognarsi per non aver osservato dei principi morali ampiamente riconosciuti e il tradire senza alcun rimorso, anzi giustificando e teorizzando il proprio atto sulla base di una morale parallela e di principi accettabili solo nello specifico campo della politica e delle relazioni internazionali.
In secondo luogo, andrebbe riconosciuto che la “dispensa morale” non è solo una cattiva morale, ma anche una pessima politica. In fondo, la ragione ultima della dispensa risiede nell’ipotetico successo che una simile condotta politica sembrerebbe garantire. La realtà è che la politica della menzogna lascia dietro di sé una scia di errori e di orrori che si accumulano e alla fine non garantiscono neppure il successo, almeno nella misura sperata. Una sorta di patto con il diavolo che si risolve nella perdita della propria anima e, con essa, anche delle ricchezze accumulate; che fine hanno fatto i dittatori, i despoti, i tiranni, i menzogneri seriali? I loro regni si sono dissolti, insieme allo svelamento delle loro malefatte.
In terzo luogo, i sistemi fondati sulla “dispensa morale”, che consente agli attori politici di esercitare la menzogna, la violenza e il tradimento dei patti, necessitano del “monopolio del segreto di fabbricazione”. Il che significa che la loro sopravvivenza dipenderà dal fatto che la stragrande maggioranza della popolazione tenga fede ai patti e si comporti secondo una morale improntata al rispetto reciproco, alla sincerità e al desiderio di pace; è un fatto che oggi, in diversi, chiedono ai resistenti ucraini di desistere dal combattere, in nome della pace, riconoscendo che la resistenza ucraina all’aggressione russa potrebbe renderci la vita ancora più difficile.
Il politico che agisce secondo la logica della doppia morale avrà tutto l’interesse che gli altri continuino a vivere secondo la morale comune, a condizione che gli riconoscano la “dispensa”, perché qualora dovessero ritirarla, la sua forza svanirebbe e il suo regime, fondato sulla menzogna, crollerebbe. Ci sarebbe sempre l’alternativa di una universale conversione alla doppia morale, ma ciò significherebbe la guerra di tutti contro tutti e l’estinzione del genere umano.
In definitiva, la logica della doppia morale che giustifica la “dispensa” accordata al politico, in nome della ragion di Stato, appare la quintessenza della politica intesa come ragione della forza bruta, del potere senza controllo, così distante dall’ideale di giustizia al quale ci si approssima per tentativi ed errori, moltiplicando i poteri, contrapponendoli ed equilibrando le forze in campo.
Da questo punto di vista, il ripensamento della logica del potere assoluto, il rifiuto radicale della ragion di stato e della doppia morale, hanno condotto Röpke e Sturzo, ma anche F.A.v. Hayek e L. Robbins e i tanti protagonisti del processo di unificazione europea, sebbene su basi teoriche non necessariamente identiche, a soluzioni istituzionali che guardano a forme progressive di federalismo tra comunità statuali liberali e democratiche che cedono, via via, quote di sovranità, una volta avviato un processo di disarticolazione della stessa, in base al metodo funzionalistico.
A questo punto, bisogna riconoscere che, così come ai fini dell’ordine interno non si ammette un’azione politica statuale non conforme alla morale individuale, ai fini della pace globale, è irrealistico immaginare un assetto istituzionale sovranazionale difforme da quello statuale. Per tale ragione, ogni tentativo di superare l’ordine internazionale fondato sull’anarchia degli Stati e di dar vita ad un sistema poliarchico di autorità che abbia la forza di bandire la legittimità stessa della guerra, richiede un ripensamento dell’assetto istituzionale presente all’interno degli Stati nazionali e il superamento della nozione di potere sovrano – dunque di Stato –, a favore di una rilettura in chiave liberale, democratica e federalista delle nostre autorità potestative nazionali.