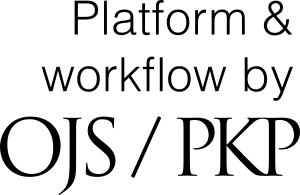“Comune è popolo”
Flavio Felice
24 settembre 2021
“Informatore.info”
C’è un piccolo paese in Abruzzo, sul confine meridionale estremo della provincia di Chieti, posto sulle pendici dell’Appennino abruzzese-molisano che si affaccia sul fiume Trigno, al cui ingresso, per chi viene dal fondo valle, in piena curva, è affissa una bacheca che ospita gli atti pubblici, in cima alla quale campeggia la scritta: “Comune è popolo”. Il paese in questione si chiama Celenza sul Trigno.
Vorrei iniziare il presente articolo da questa immagine che mi è tornata in mente leggendo il bel libro di Rodrigo Cieri: “Il mio universo. Persone ed eventi tra due millenni. Persone ed eventi tra due millenni”, il Torcoliere, 2021.
Il tema ricorrente del libro è il “tempo”. Il tempo come categoria della politica, una pratica tutta umana, storica, contingente, i cui attori protagonisti si prefiggono l’obiettivo di conquistare, mantenere e trasferire il potere, ricorrendo all’utilizzo di mezzi legittimi. La considerazione del tempo come categoria politica è tutt’altro che originale, soprattutto se la si confronti con lo spazio; la categoria che indica l’occupazione del potere e che ne perimetra il mandato: la sovranità.
Il tempo interessa la dimensione processuale della politica e ci consente di cogliere il dinamismo del potere nel suo divenire, nel suo mutare; in pratica, il tempo ci offre una dimensione processuale del potere, i cui attori protagonisti sono le persone singole e organizzate in una miriade di modi differenti, più o meno spontanei.
Il tempo ci dice che il potere, inteso come la disponibilità legittima della forza, non è nulla di astratto, né tanto meno di innato, ci dice inoltre che non può essere gelosamente e segretamente custodito in qualche recondito scrigno: gli arcana imperii. Non c’è nulla di più concreto, storico e tangibile del potere, esso si “costruisce” nel “tempo”, si “conquista” nel “tempo”, si “mantiene” nel “tempo” e si “trasferisce” nel “tempo”.
Il tempo è la dimensione nella quale il potere prende forma, e la qualità del tempo disegna anche la sua forma, ci dice la sua stratificazione, rivela gli interessi che difende, denuncia le ingiustizie che perpetua e gli ideali che persegue, rivela la sua capacità di resistere agli urti dei contropoteri e confessa quanto meriti di essere difeso ovvero abbattuto. In definitiva, il “tempo” scandisce la genesi e la parabola del potere, al di là della sua stessa dimensione spaziale; se si tratti di un minuscolo borgo o del governo del mondo.
A differenza del “tempo”, lo “spazio” ci offre un’istantanea sul potere e ne perimetra la “stabilità”, informandoci circa la sua dimensione statica, dove è possibile isolare i singoli elementi, modificarli, sostituirli, correggerli, come un chimico farebbe in un asettico laboratorio di analisi; è questa la dimensione statica del potere e anche la condizione essenziale affinché il processo dinamico si sedimenti in una forma di governo che ne cristallizzi il “divenire”; tale dimensione del potere, storicamente, ha assunto la forma dello “Stato”, non a caso, il termine coincide con il participio passato del vero “essere”.
Nel suo divenire, il “processo politico” richiede strumenti flessibili e catene di comando corte, oltre che relazioni di tipo orizzontale, tra loro interconnesse. Richiede una vitalità e una predisposizione al cambiamento che invitano tutte le parti che vi partecipano ad un perenne esercizio di autogoverno, di autodisciplina e di controllo reciproco; non esiste uno stadio del processo in cui alcuna delle parti possa dormire sonni tranquilli per dedicarsi alla contemplazione del risultato raggiunto.
Di contro, nella sua staticità, “l’istantanea politica”, risponde al carattere della “stabilità” e mal tollera l’attivismo delle relazioni orizzontali, spontaneamente interferenti, potenzialmente confliggenti, mentre ripone la sua fiducia nelle catene di comando lunghe e rigide, fortemente burocratizzate e inclini alla conservazione delle posizioni acquisite.
È evidente che stiamo descrivendo due dimensioni idealtipiche. Tuttavia, esistono forme potestative che prediligono la dimensione dinamica e altre quella statica; le prime danno il meglio di sé se interpretate ricorrendo alla logica processuale, le secondo se interpretate a partire da quella spaziale.
In pratica, il “comune” risponde meglio al dinamismo del processo politico, mentre lo “Stato”, per definizione e per le ragioni storiche che l’hanno prodotto ed esaltato in epoca moderna, appare più aderente all’immagine dell’istantanea politica.
Il comune è storicamente l’espressione delle relazioni orizzontali, dello scambio di beni e servizi, della sicurezza ottenuta mediante l’autogoverno dei suoi tanti ordini, del reciproco controllo che produce anche tensioni, conflitti, vinti e vincitori; una circolazione delle posizioni del potere, nei confronti della quale il potere costituito: l’impero, la chiesa e, successivamente, lo Stato hanno sempre diffidato, nutrendo timore e mostrando profonda insofferenza nei confronti del comune. Di qui, l’affermazione che il comune si amministra, lo stato si governa.
Sappiamo che amministrare significa “servire”, il verbo “amministrare” deriva dal latino administrare, agire da ministro, servire con oculatezza, ponderazione e giustizia; colei o colui che raziona la minestra non può non tener conto delle esigenze dal basso, ci coloro che hanno fame, per questa ragione l’amministrare è una pratica del potere dinamica, particolarmente sensibile alla dimensione ascendente bottom-up e sussidiaria, soprattutto in senso orizzontale. Di contro, “governare” significa “dirigere”, il verbo “governare,” deriva dal latino gubernaculum, che stava ad indicare il remo-timone delle imbarcazioni. Governare significa dunque imprimere la direzione del governante ai governati e, di conseguenza, è particolarmente sensibile alla dimensione discendente di tipo top-down, quanto di più distante dal principio di sussidiarietà.
Potremmo anche dire che, mentre il principio che muove l’azione di governo è di tipo monistico, nel senso che gli svarianti interessi tendono a essere incanalati nella linea che i detentori del potere decidono essere prevalente ai fine del raggiungimento di un ipotetico interesse generale, l’amministrazione rinvia ad un principio di tipo poliarchico, dato il riconoscimento, di fatto, di una miriade di centri potere, ciascuno dei quali relativo ad una fonte che gli è propria, al punto da disegnare una società irriducibilmente “plurarchica”, dove il problema del buon governo si risolve nella governance degli innumerevoli “buoni governi” presenti nel comune.
Emblematico, in tal senso, è il ciclo pittorico del Lorenzetti esposto nella sala dei Nove del palazzo civico in Piazza del Campo a Siena. L’opera si compone di tre elementi: 1. L’allegoria del buon governo; 2. Gli effetti del buon governo; 3. Gli effetti del cattivo governo. In circa sette secoli di storia, tante sono state le interpretazioni di tale opera e numerosi sono stati i politologi e i filosofi che se ne sono occupati. Il comune non nasce come entità politica omogenea, non è un caso che i nomi delle città, in origine, erano spesso al plurale, proprio per indicare la pluralità dei centri d’interesse che si riunivano in un territorio per potersi difendere meglio e per massimizzare la loro funzione di benessere; la stessa Siena, disegnata dal Lorenzetti, è presentata nel dipinto con l’acronimo C.S.C.V.: “Commune Senarum Civitas Virginis” (“Comune di Siena Città della Vergine”); il nome latino di Siena è al plurale (Saenae) e molto probabilmente sta a significare che il “commune” fu l’unione di più parti, un’antica colonia etrusca costituita da piccoli insediamenti sparsi sui tre colli che presidiano la valle della Tressa.
La plurarchia e la poliarchia all’interno delle città sono da sempre considerate delle costanti e le cause di diffidenza che imperatori e papi hanno nutrito per l’autonomia dei comuni. Il particolarismo e il pluralismo interno alle città, che apparivano come un elemento di debolezza al cospetto dell’universalismo dell’impero e della Chiesa, nel mondo globale di oggi, di fronte alla comparsa della global city, esprimono la più grande forza di questa entità civile, il suo valore aggiunto, un modello di società libera, inquadrabile nell’esperienza storica e nel contesto teorico einaudiano del “buon governo”.
Il comune, a differenza, dello Stato, non è riducibile ad una entità politica, essa certamente presenta al proprio interno un ambito politico, ma è ancor prima una realtà produttiva, commerciale, di difesa, religiosa, culturale, intergenerazionale, interculturale e interetnica. Tutte queste dimensioni non sono sintetizzate e omogeneizzate dalla politica e, tantomeno, dallo Stato; esse, oltre a pretendere autonomia dalla politica, si trovano spesso in competizione l’una con l’altra. Talvolta emerge l’una, altre volte emerge un’altra, nessuna può vantare un preteso primato; politica, economia e cultura, con tutte le relative articolazioni, competono, quota parte, a dar vita alle condizioni affinché ciascuna persona possa perseguire il proprio bene. Il bene di ciascuno, ricercato in condizioni di reciproca interferenza dei singoli ambiti, delle persone, degli interessi, dei partiti, delle fazioni, dei valori e degli ideali che compongono l’ordito civile che più si avvicina, per approssimazione, alla nozione di bene comune, inteso come il metodo di azione civile che favorisce il bene di tutti e di ciascuno.
Questa interpretazione della vita comunale, definita “buongoverno”, distinta dall’azione del governo statuale, è incisa sulla tavola pittorica del ciclo senese del “buongoverno”, allorché, in corrispondenza della personificazione della città di Siena troviamo l’incisione che segue:
«Questa sancta virtù [la Giustizia], là dove regge / induce ad unità li animi molti / e questi, a cciò ricolti / un ben comun per signor si fanno»
La giustizia, che nella fattispecie è intesa nella sua dimensione correttiva e procedurale, lì dove ordina la vita della città, legando gli amministratori al dovere di servitori, fa sì che le tante realtà presenti, i tanti conflitti d’interesse, i tanti valori e ideali in contrasto tra loro (i tanti governi), si raccolgano intorno a delle regole comuni, in modo che a governarli non sia un “sovrano”, bensì il “bene comune” stesso: le regole della civile convivenza che normano il conflitto, rendendolo civile, senza per questo negarlo.
Il “bene comune”, in questa accezione, non è altro che le regole che in “comune” persone ignoranti e fallibili si danno e che in “comune” si impegnano reciprocamente di rispettare. Quel “reciprocamente” e quel “in comune” sono gli elementi che perimetrano e caratterizzano qualitativamente il “popolo”; e qui vorrei tornare all’iscrizione presente sulla bacheca all’ingresso di Celenza: “Comune è popolo”.
Il comune diventa la forma di governance più vicina alle persone, non tanto e non solo perché tutti conoscono il sindaco, gli assessori e i consiglieri, ma perché sembra maggiormente in grado di esaltare i caratteri costitutivi di una nozione di popolo, non tribale, né mistica, refrattaria, dunque, al populismo e, di conseguenza, degna della società aperta. Il popolo come comunità di persone e di enti concorrenti, articolato e declinato al plurale: il people della lingua inglese; persone che, in gran parte, condividono le medesime regole del gioco e una “comune” idea su come dovrebbe svolgersi il processo democratico: “discussione critica su questioni di interesse comune”.
Questi sono i caratteri del “popolo” non populisticamente inteso, caratteri che fanno di tale soggetto plurale il primo e fondamentale argine all’abuso di potere, da qualunque parte venga, diga all’esercizio illimitato del potere, alla pretesa arbitrarietà dei governanti, alla discrezionalità della politica, imposta ai governati sempre nel nome di imperscrutabili arcana imperii.
“Comune è popolo” è la forma di governance che rende evidente la teoria politica del “popolarismo” sturziano; il popolo come limite organico, politico e morale all’esercizio del potere. È questa forma di governance che nutre le procedure democratiche, altrimenti descrivibili solo mediante freddi universali procedurali che, oltretutto, la storia e la recente cronaca dei fatti afghani si sono incaricate di mostrarci che tanto universali non sono.